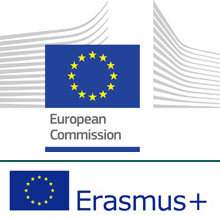Come possiamo combattere insieme le mafie in Europa?
L’intervista è stata condotta dalla dottoressa Mona Lisa Carai nell’ambito della sua tesi di dottorato “Die Strafbarkeit mafiöser Vereinigungen in Deutschland: Zur Reformbedürftigkeit von § 129 StGB im Rahmen der Verfolgung Organisierter Kriminalität vor dem Hintergrund der italienischen Rechtslage”, che è stata pubblicata ad agosto 2025.
SPARAGNA Roberto Maria, nato ad Acuto (FR) il 10.05.1965. In magistratura dal luglio 1994, ha svolto la funzione di sostituto procuratore presso il Tribunale di Torino. Dal 2003 al 2013 ha fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia del Piemonte. Si è occupato di diversi omicidi (tra i quali quelli commessi dal cd. serial killer MINGHELLA Maurizio) e di indagini concernenti la presenza di organizzazioni di stampo mafioso in Piemonte. In particolare, ha svolto indagini sulla ‘ndrangheta in Piemonte (tra queste si ricorda l’operazione denominata “Minotauro”), sulla mafia siciliana e sulle mafie straniere. Ha svolto le indagini e seguito il processo (conclusosi con sentenza ormai definitiva) sull’associazione anarchica insurrezionale denominata Federazione Anarchica Informale- Fronte Rivoluzionario Internazionale. Nel 2018 si è occupato dei fatti noti come “il disastro di Piazza San Carlo” avvenuto il 3.6.2017 nell’omonima piazza torinese. Dal gennaio 2020, svolge le funzioni di sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo avente sede in Roma.
Carai: Che sviluppo prevede nel prossimo futuro per le organizzazioni criminali anche di stampo mafioso e quali misure penali suggerisce di implementare per combattere tempestivamente tale fenomeno e non anni dopo il consolidarsi di nuovi modus operandi criminali?
Sparagna: Le attività criminali svolte negli ultimi anni dalle organizzazioni di stampo mafioso attestano il proliferare di condotte sempre più indicative dell’interesse verso la prestazioni di servizi illeciti. Accanto alle attività delinquenziali che potremmo dire tradizionali – come ad esempio il narcotraffico, le estorsioni, il traffico di armi – vengono offerti al mercato degli imprenditori disonesti alcuni servizi illeciti che spaziano dall‘intermediazione illecita di manodopera, all’emissione di false fatturazione e consumazione di truffe erariali e allo smaltimento irregolare di rifiuti. A ciò, si aggiungono le condotte di riciclaggio e reimpiego dei proventi delle attività criminali che non solo producono un enorme arricchimento delle compagini mafiose, ma alterano la libera concorrenza e il mercato. Si tratta di fenomeni che hanno rilevanza non solo nelle regioni italiane, specie del Nord del Paese, ma anche in altri Paesi dell‘Unione Europea e di altri continenti. Di qui, la necessità di adottare comuni strategie di repressione e di condividere le esperienze legislative e giudiziarie che hanno permesso di raggiungere risultati utili e positivi nel contrasto e nella prevenzione della diffusione e radicamento delle organizzazioni mafiose. Penso, ad esempio, al sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniali che dovrebbe essere, a mio giudizio, maggiormente conosciuto ed applicato nei diversi Stati dell’Unione europea. Negli ultimi anni sono stati fatti enormi progressi (penso alla normativa comunitaria in materia di Ordini Investigativi europei, di Squadre investivìgative comuni e agli interventi in tema di sequestro e congelamento) ma occorre sviluppare ancor di più la cooperazione giudiziaria che trova nell’uniformità normativa e anche giurisprudenziale il suo naturale presupposto.
Ritiene che la figura del concorso esterno abbia rilevanza solo nel contrasto alla mafia o anche ad altri tipi di organizzazioni criminali?
Il concorso esterno è un istituto che trova applicazione anche in settori del diritto penale diversi dalle contestazioni associative mafiose. E‘ infatti applicabile a tutte le forme di reato associativo (così, associazione semplice ex art. 416 c.p., associazione ex art. 74 DPR 309/90 sui sodalizi dediti al narcotraffico, alla associazioni che praticano il contrabbando di tabacchi, a quelle che gestiscono l’immigrazione clandestina e la prostituzione, etc.). Il concorso esterno consente di contestare il reato associativo anche a coloro che, pur non facendo parte del gruppo criminale (ad esempio non sono stati affiliati e comunque non possono ritenersi partecipi per facta concludentia del sodalizio) finiscono per agevolarlo o rafforzarlo.
Quali sono le prioritá e le difficoltá sulle quali la Germania e la UE, sulla base dell´esperienza italiana, dovrebbero concentrarsi per un contrasto penale piú efficace delle associazioni per delinquere anche di stampo mafioso?
Innanzitutto, il reato associativo nella sua elaborazione teorica non è riconosciuto in alcuni ordinamenti statali che non conoscono altre modalità di manifestazione del reato diverse dalla fattispecie monosoggettiva o concorsuale. Inoltre, spesso non trova un condiviso riconoscimento la stessa configurazione del reato associativo mafioso, illecito nel quale la forza che promana dal vincolo associativo rende i consociati ( o alcuni settori della comunità) omertosi e reticenti. In altre parole, spesso gli inquirenti italiani trovano difficoltà a far comprendere l’essenza del metodo intimidatorio e in cosa consiste l’estrinsecazione dello stesso metodo. In altri termini, le Autorità straniere non sempre sono pronte a recepire la differenza tra crimine organizzato e associazione mafiosa. Tale aspetto mi pare estremamente interessante poichè riduce le potenzialità della cooperazione giudiziaria a fronte dell’espansione in Europa e anche in altri Paesi della mafia e in particolare della ndrangheta. Come noto, infatti, la ‚ndranheta è presente in Canada, negli Stati Uniti, in Australia, in sud America e in Messico.
Quali sono i principi giuridici sviluppati dalla dottrina e giurisprudenza italiana che ritiene necessari per un efficace contrasto alla criminalitá organizzata anche di stampo mafioso ma potenzialmente di difficile assimilazione in altri sistemi giuridici europei come quello tedesco e perché?
Richiamo in primo luogo quanto già osservato nella risposta alla domanda nr. 3. A tale osservazione deve aggiungersi il potenziamento del contrasto all’arricchimento illecito delle mafie. Occorre infatti potenziare l’applicazione degli strumenti previsti dalla legislazione italiana in tema di misure di prevenzione ivi compresi gli istituti meno invasivi del sequestro e della confisca che nell’ordinamento italiano consentono una strategia di intervento meno invasivo e ispirato al principio di proporzione (così, gli istituti dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario dei beni). L’assimilazione di tali istituti in altri Paesi diversi dall’Italia trova difficoltà applicative poichè si tratta di provvedimenti di vincolo che prescindono da una sentenza di condanna, ma fondano sulla nozione di pericolosità „qualificata“ del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Ritengo inoltre che sia di difficile assimilazione il tema della mafia silente che si ha quando la presenza mafiosa è talmente sentita che il gruppo criminale non ha più neppure bisogno di minacciare (direttamente o indirettamente) per costringere comunque i consociati a fare, non fare o tollerare qualcosa.
Quali sono le difficoltá per la magistratura inquirente derivanti dalla internazionalizzazione delle attivitá criminali di stampo mafioso?
A quanto finora osservato, si aggiungono delle difficoltà di tipo concreto, spesso dovute alle diverse regole circa le tecniche investigative esistenti nei diversi Paesi. Intendo riferirmi, ad esempio, alle tecniche di pedinamento o al tema delle intercettazioni ove talora la disciplina, specie con riferimento all’utilizzabilità dei risultati captati, è differente nei diversi ordinamenti. Così, con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali, l‘utilizzo dei risultati di intercettazione quando uno degli interlocutori sia non identificato; oppure, l’ipotesi della sospensione delle operazione di intercettazione prevista in alcuni ordinamenti quando gli interlocutori non parlano di questioni attinenti al reato ma di vicende personali. Oppure, il cambio della targa sull’autovettura sottoposta ad intercettazione. Si tratta di fattispecie che in altri Stati rendono inutilizzabile il risultato intercettivo. Oppure, si pensi alle limitazioni in ordine al concreto svolgimento die servizi di osservazione e di pedinamento spesso limitati in alcuni Stati all’orario di servizio degli agenti di polizia giudiziaria. In breve, non solo occorre una maggiore condivisione degli istituti giuridici elaborati in tema di contrasto alle organizzazioni mafiose, ma anche una maggiore uniformità negli strumenti investigativi concretamente esperibili.
Quali ritiene siano i punti di maggior contatto le differenze principali tra le associazioni terroristiche e quelle mafiose riguardo alla struttura dell´associazione criminale?
Innanzitutto, occorre osservare che il terrorista è un delinquente che è determinato da motivazioni ideologiche (essenzialmente politiche o confessionali) che tenta di abbattere o disarticolare il sistema Statale. Egli si pone in una situazione di contrasto con l’ordinamento poichè mira all’abbattimento del dominio“ termine utilizzato per indicare le fondamentali istituzioni politiche, amministrative e economiche. Il mafioso, invece, frequentemente cerca di insinuarsi negli apparati Statali e tenta, finchè è possibile, di non arrivare allo scontro con le Istituzioni statali mirando piuttosto a sfruttarle. Il mafioso cerca di convivere con il potere talvolta sostituendosi ad esso, ad esempio, nel controllo del territorio. La mafia inoltre tenta di condizionare il potere politico e di ottenere benefici. Dal punto di vista della struttura dell‘ associazione, quella terroristica in epoca recente è caratterizzata sempre più dalla cosiddetta „smaterializzazione“. In altre parole, specie con riferimento al terrorismo di matrice religiosa, si assiste ad un rapporto di adesione biunivoca a strutture criminali aventi sede all’estero ( si pensi all’ISIS, o ad Al Qeida). Spesso si tratta di singoli o gruppi che aderiscono a reti terroristiche le quali spesso diffondono proclami e strategie in internet nonchè addestrano all’uso delle armi e di esplosivi. Di conseguenza, non sempre dalle indagini emergono i classici elementi probatori, specie di carattere oggettivo, da cui desumere l’esistenza di covi, armi o beni in comune, ripartizione die ruoli associativi, etc.. L’associazione mafiosa o l’organizzazione criminale appaiono, invece, maggiormente strutturate. Esse tuttora dispongono di beni in comune (così, la cassa; l’utilizzo di covi, l’utilizzo di telefoni criptati, etc.), utilizzano procedure per l’ingresso e la progressione nel grado dell’organizzazione criminale, ricorrono a una rigida ripartizione dei ruoli associativi. Esse inoltre possono contare su un contesto sociale talvolta protettivo o comunque tollerante.
Ritiene utile e possibile la creazione di una legislazione armonica anti mafia a livello europeo e perché?
Per quanto finora osservato, ritengo non solo utile ma indispensabile l’armonizzazione della legislazione antimafia a livello europeo in una prospettiva di un’efficace cooperazione giudiziaria. Il perchè è presto detto: è l’unico strumento idoneo a contrastare l’evidente espansione della mafia. Peraltro, l’esperienza giudiziaria dimostra che le organizzazioni mafiose spostano i loro affari illeciti nei territori ove il contrasto è meno efficace e dove possono operare indisturbate finendo per condizionare l’economia e la stessa vita democratica del Paese (si pensi ai fenomeni connessi al voto di scambio). Inoltre, le organizzazioni mafiose sempre più spesso operano congiuntamente e creano macroassociazioni che ad esempio, gestiscono il narcotraffico dal sud America. Sempre più spesso utilizzano criptovalute e i mercati del dark web, spostano e riciclano capitali utilizzando Paesi terzi meno propensi alla cooperazione giudiziaria (così, la Cina, la Turchia, etc.). Insomma, si assiste a fenomeni che indicano l’internazionalizzazione degli affari e dei tavoli su cui opera la mafia (si pensi alle relazioni con le organizzazioni criminali della cd. „Tripla frontera“ sudamericana).
Quali sono gli elementi di maggior criticitá ed interesse che emergono dalle Sue conversazioni con i colleghi della magistratura inquirente stranieri riguardo la partecipazione alle associazioni criminali di stampo mafioso?
Le criticità concernono, come già anticipato, la stessa nozione di criminalità mafiosa. Quanto alla partecipazione all’associazione mafiosa rileva il tema della valenza probatoria della semplice affiliazione rituale. In altre parole: è sufficiente la mera affiliazione a dimostrare la partecipazione associativa in assenza di altri elementi? Si tratta di un tema oggetto di riflessione anche in Italia. Altro tema di discussione e riflessione riguarda l’individuazione delle condotte che dimostrano la partecipazione associativa. Così la partecipazione a riunioni riservate, il conferimento di doti, la comunicazione di messaggi e informazioni qualificate (le cd. ambasciate), la commissione di particolari reati scopo, etc.
Quali ritiene siano dei casi di criminlitá organizzata che l´ordinamento giuridico italiano disciplina particolarmente bene e che potrebbero servire da modello per la EU e altri ordinamenti?
Non penso che l’ordinamento italiano disciplini „particolarmente bene“ un istituto giuridico nel contrasto alla mafia. Molti strumenti sono oggetto di critica dottrinale talvolta le questioni sollevate sono accolte da pronunce giurisprudenziali. Ricordo, al riguardo, la natura emergenziale della normativa antimafia, come quella in materia di terrorismo. Ritengo che la riflessione comunitaria possa soffermarsi sull’estensione dell’applicazione degli istituti in materia di misure di prevenzione che, come detto, sono molto utili per contrastare l’arricchimento delle associazioni mafiose e la loro diffusione sul territorio di Paesi non autoctoni.
Foto: (c) Roberto Sparagna